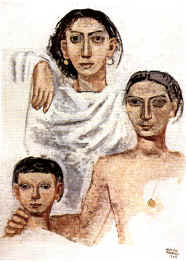 Il
formarsi di una nuova coscienza moderna sta alla base del conflitto tra padri e
figli che emerge con forza nell’immaginario del primo Novecento. Questo
complesso rapporto si collega a una precisa condizione storica, caratterizzata
dalla rivolta dei giovani contro i padri: il mito giovanilistico invade infatti
i nuovi movimenti politici, nazionalisti e sindacalisti-rivoluzionari.
Il
formarsi di una nuova coscienza moderna sta alla base del conflitto tra padri e
figli che emerge con forza nell’immaginario del primo Novecento. Questo
complesso rapporto si collega a una precisa condizione storica, caratterizzata
dalla rivolta dei giovani contro i padri: il mito giovanilistico invade infatti
i nuovi movimenti politici, nazionalisti e sindacalisti-rivoluzionari.Vengono meno i parametri consolidati in campo scientifico-tecnologico, basti pensare alla teoria relativistica di Einstein, dove si perde il concetto di spazio e tempo assoluti, o alla fisica quantistica di Planck, che introduce innovazioni nel mondo della scienza.
Si diffondono nuove correnti d’avanguardia artistiche e letterarie, dagli espressionisti ai futuristi e in filosofia rivestono un ruolo di notevole importanza i pensieri di Nietzsche e Schopenhauer che, discostandosi dalla tradizionale visione della realtà, concepiscono la vita come dolore e affermano una caduta delle certezze e dei valori assoluti.
Con la scoperta del complesso di Edipo, Freud, all’inizio del secolo, interpreta in senso psicologico la rivalità tra padre e figlio, diventando il maestro di una generazione in rivolta che tenta di uccidere i propri padri e di costruire un mondo del tutto nuovo.
Tutto ciò contribuisce alla rottura tra “vecchi” e giovani: l’atteggiamento di questi ultimi, distruttivo verso il passato, e l’esaltazione del nuovo, della rivoluzione o anche della guerra rientrano nella simbolica “uccisione” dei padri e della società che essi rappresentano.
I genitori esprimono la completa adesione al contesto sociale borghese del tempo, sono portatori dei valori di stabilità e conservatorismo e si impongono sui figli con autorità in alcuni casi, divenendo una figura possessiva e violenta, che umilia continuamente il figlio “diverso” da lui, o provocando in loro una repressione indiretta e inconscia in altri, che fa nascere nel figlio il senso di colpa, di disadattamento e di impotenza.

Il figlio giunge a provare nei confronti del padre non solo odio, ma allo stesso tempo anche invidia e gelosia per la sua stabilità sociale, economica e interiore.
L’unico motivo di riscatto del figlio è il poter contare su un senso di superiorità intellettuale, che gli permette di essere “migliore” del padre almeno in un aspetto del vivere.
La nuova generazione personifica l’inadeguatezza ai valori della società contemporanea e l’incapacità di accettare le certezze dei padri, il bisogno di cambiamento, di superamento e di distruzione del vecchio; da qui emerge l’incomunicabilità, la lontananza e l’incomprensione tra questi due modelli di vita.
L’aggressione ai padri produce inetti e ribelli. Troviamo dei figli, quali Zeno di Svevo, Vitangelo di Pirandello, Pietro di Tozzi, che non possiedono né indipendenza economica né ruolo sociale, il cui atteggiamento sfocia nell’inettitudine e nella malattia interiore, oppure giovani la cui opposizione alla società si rivela tramite la ribellione e il rifiuto, tipici del movimento futurista.
Significativo è anche il cambiamento della figura femminile, che vediamo emergere nel tessuto sociale e divenire protagonista di un romanzo come ne L’Esclusa di Pirandello, personificando i valori contrastanti alla società in cui vive.
E’ ben diverso quindi il conflitto che viene a stabilirsi tra padri e figli in questi primi decenni del Novecento rispetto a quello precedente dell’Ottocento; se in quest’ultimo il conflitto ha origine da motivi ideologici, nel Novecento la crisi tra padre e figlio è dettata da fattori psicologici (Saba) che trovano spiegazione soltanto a livello dell’io e della psiche del protagonista; rivelatrice a questo proposito è l’interpretazione di Freud, che per primo ricerca l’origine dei complessi dell’uomo nel suo inconscio.