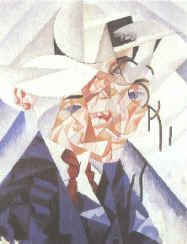 Il
1926 è
l'anno di pubblicazione a puntate sul settimanale La
Fiera letteraria.
Il
1926 è
l'anno di pubblicazione a puntate sul settimanale La
Fiera letteraria.Il romanzo, l’ultimo scritto da Pirandello, fu ideato come “introduzione” alla lunga stagione teatrale, ma dopo una lunga gestazione finì per risultare una sorta di ragionato sommario delle tematiche, delle concezioni ideologiche e delle innovazioni stilistiche dell’autore. Si presenta così come un lungo monologo in prima persona, all’interno del quale viene appunto raccontata la storia del protagonista-narratore: Vitangelo Moscarda (detto Gengè), figlio di un ricco usuraio, tranquillo provinciale ventottenne, “grazie” all’osservazione della bella moglie Dida riferita al suo naso che “pende verso destra”, si accorge per la prima volta che la sua vita banale, inconsistente e senza veri ideali né responsabilità, non ha una “forma fissa” neanche nel suo aspetto fisico.
Questo lo porta ad una crisi devastante, ad un continuo interrogarsi sulla sua identità: propone quindi a se stesso “sette comandamenti” per tentare di scoprire il suo vero io, basati su alcune riflessioni chiave. Tra queste le più importanti sono: il sentirsi diverso da quello che aveva creduto di essere fino ad allora e il non potersi veder vivere.
Moscarda è un uomo inetto, impossibilitato a realizzare la propria personalità e non si ama. Si è sposato per convenzione, si ribella contro il padre e contro l’amministratore e amico Quantorzo, che ne è un “fax-simile”. Al mondo che lo circonda egli si ribella in maniera attiva, come è provato dal furto degli incartamenti di una casa da cui vuole sfrattare l’inquilino Marco di Dio, al quale successivamente, con lo stupore di tutti, finisce per regalare un appartamento. Incolpa il padre perché da lui ha ereditato la fama di usuraio e per togliersi finalmente di dosso questa “immagine-maschera”, si dà ad elargizioni e propone di liquidare la banca.
I soci, gli amici e la moglie cominciano a giudicarlo pazzo e lo vogliono interdire; con l’aiuto di Anna Rosa, amica della moglie, Vitangelo si accorda con il vescovo per devolvere i propri beni in opere di carità. Dimostrandosi così gentile, egli cerca di baciare Anna Rosa, ma questa, sconvolta dal suo modo di ragionare, gli spara con una pistola ferendolo gravemente. Per il processo, si reca in tribunale con la stessa divisa dei mendicanti che vivono nell’ospizio, che egli nel frattempo ha fatto costruire con i soldi dell’eredità, e scagiona la donna attribuendo l’accaduto al caso. Dopo aver corso il rischio di diventare “uno”, di acquisire un’identità sociale o maschera convenzionale, che ne farebbe in realtà il riflesso dei “centomila”, è diventato finalmente “nessuno”: infatti ormai ha raggiunto la “guarigione”, tutto immerso nel fluire insensato della vita, senza nome, senza identità, senza pensieri e persino senza inconscio.
(relazione)