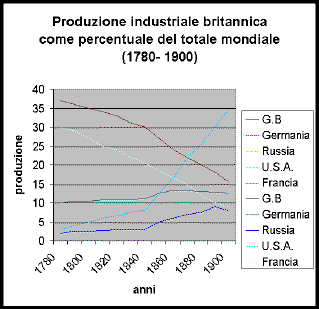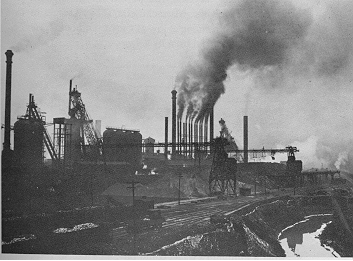Principali Casi della Seconda
Fase dello Sviluppo Industriale
Francia
La Francia fu una delle
prime nazioni a seguire le orme della Gran Bretagna. Allo scoppio della
rivoluzione (e forse tutto il secolo precedente) essa era un paese arretrato, in
fatto di produttività media, rispetto all’Inghilterra. Non si trattava però,
a giudicare con criteri moderni, di un distacco molto ampio. I due paesi avevano
in comune lo stesso retaggio culturale e sociale europeo-occidentale. Se ha
senso parlare di “fasi” di sviluppo economico, è lecito dire che Francia ed
Inghilterra si trovavano negli anni 1780 sostanzialmente nella stessa fase. Per
taluni riguardi i francesi erano anzi in vantaggio. Essi facevano già leva su
una forte tradizione scientifica; la creazione nel 1794 dell’Ecole
Polytechnique, il primo istituto di scienza applicata del mondo, e più
tardi (1829) quella dell’Ecole Centrale Des Artes et Manufactures per
educare proprietari e gestori di fabbriche ai principi dell’industria
scientifica, non sono che due dei casi in cui i francesi parvero a volte più
progrediti degli inglesi nel modo di impostare lo sviluppo economico. Anche
durante la guerra, i provvedimenti adottati dal governo per stimolare
l’industria chimica trasformarono quest’ultima da un insieme di pochi e
sparsi stabilimenti di modeste dimensioni in una grande industria diversificata.
Questi progetti avrebbero potuto segnare una svolta; di fatto, o rimasero
isolati o abortirono. Quando la pace aprì le porte del mercato europeo,
l’industria chimica pesante inglese raggiunse e superò rapidamente quella
francese. Né l’Ecole Polytechnique né l’Ecole Des Artes si
rivelarono istituzioni propagative di sviluppo. Ancora all’inizio degli anni
1850 più di metà della produzione siderurgica francese usciva da forni a
carbone di legna, che decaddero soltanto dopo la crisi del 1856. Si è calcolato
che nel 1847, in tutta l’industria francese, c’erano meno di 5000 macchine a
vapore, con una potenza di appena 62000 cavalli. Solo negli anni 1830
l’industria cotoniera casalinga cominciò a declinare di fronte alla
concorrenza delle fabbriche. Anche lo sviluppo dell’era delle ferrovie fu
incerto: al termine del primo boom ferroviario, nel 1845, erano in funzione in
Francia soltanto 1900 Km circa di binari.
La caratteristica più singolare della rivoluzione industriale in Francia fu in
effetti la gradualità del suo sviluppo. In base a tutti gli indici di
industrializzazione la Francia era superata, prima dell’inizio del XX secolo,
dagli Stati Uniti, dalla Germania e dal Belgio. L’agricoltura, che si è
calcolato contribuisse al reddito nazionale per il 59% nel 1789 e per il 46,5%
nel 1845, nel 1890 era ancora pari al 35% circa del totale.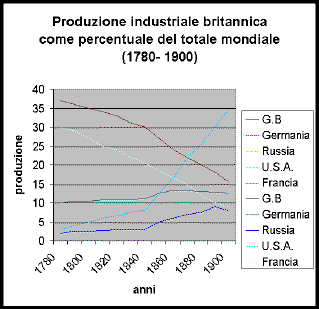
A lungo andare, naturalmente, si sono avuti mutamenti sostanziali nella
struttura dell’economia francese, anche se la trasformazione è stata graduale
e meno pronunciata che in Inghilterra e in altri paesi industriali. A prima
vista, per altro, può sembrare sorprendente che la disparità fa i livelli di
reddito francese e inglese non risulti essere aumentata nel corso degli ultimi
due secoli. I documenti suggeriscono che nonostante la relativa arretratezza
dell’industria francese, il reddito reale medio è aumentato all’incirca
nella stessa misura in Inghilterra e in Francia. Il ritmo di sviluppo è stato
bensì alquanto diverso nei due. In Inghilterra e in Francia, come in altri
paesi industriali, l’aumento della produttività ha avuto riscontro, oltre che
nell’ascesa dei redditi reali, in un accorciamento della giornata
lavorativa.
Ma la Francia, a differenza dell’Inghilterra, è tuttora prevalentemente un
paese di piccoli produttori indipendenti, sui quali poco hanno influito i
mutamenti sociali che hanno portato un aumento di tempo libero per la
popolazione salariata. Se nella Francia rurale l’incremento di reddito pro
capite è stato pari a quello dell’Inghilterra industriale, ciò forse
significa semplicemente che un
numero maggiore dei suoi abitanti ha continuato, per guadagnare questo reddito,
a fare lunghi orari nei negozi e nei caffè, nelle piccole aziende agricole e
nelle officine artigiane. (Storia Economica Cambridge)
Germania
Gli esordi della trasformazione
industriale, a imitazione diretta dell'esempio britannico, risalgono alla fine
del XVIII secolo. Nei decenni 1780-1790 anche i tedeschi, come i francesi e i
belgi, si infiltrarono nelle fabbriche inglesi, contrabbandando in patria i
segreti delle nuove tecnologie . Henderson cita parecchi esempi, già in questi
anni, di nuove fabbriche tessili tedesche attrezzate con macchinari inglesi e
fatte funzionare da lavoratori inglesi. Questi erano fatti isolati. Nonostante
le sovvenzioni statali, la risolutezza di taluni imprenditori e vari esperimenti
promettenti, l'industria tedesca rimase eminentemente arretrata fino alla
seconda metà dell'Ottocento. Nel settore agricolo, invece, la trasformazione fu
più radicale e di più vasta portata nella prima metà dell'Ottocento. La
rottura degli schemi tradizionali dell'agricoltura tedesca, grazie
all'emancipazione dei contadini per esempio, aprì la via ad una rivoluzione
agricola e demografica. Si è stimato che fra il 1816 e il 1865, in parte per
l'estensione dell'area coltivata e in parte grazie ai metodi di coltura più
intensivi ed efficienti, la produzione zootecnica aumentò del 213% e quella
agricola del 62% rispetto ad un incremento demografico del 59% circa. Dato che
in Germania l'agricoltura è l'attività economica di gran lunga più
importante, ciò è indice di un sensibile aumento del reddito reale medio. La
spinta dell'agricoltura sembra si esaurisse negli anni del 1860. Fra il 1865 e
1890, si stima che la produzione agricola crebbe più lentamente della
popolazione, e ad un tasso più che dimezzato rispetto al cinquantennio
precedente. Essa può aver contribuito ad avviare un processo di crescita
continua, ma che facesse parte di tale processo non è cosa ovvia. In effetti
per trovare documenti sulle origini di una crescita continua dobbiamo guardare
agli sviluppi dei settori economici extraagricoli. Lo Zollverein (unione in
vigore tra gli stati germanici dal 1834 al 1871; dominata in un primo tempo
dall'Austria, divenne sotto la guida prussiana un fattore decisivo nel processo
di unificazione tedesco – Enciclopedia DeAgostini) entrò in vigore nel
primo gennaio 1834, e venne esteso gradualmente. Fu il primo grande passo verso
l'unità economica della Germania, ed ebbe l'effetto di portare i ventitré
milioni e mezzo di abitanti degli stati tedeschi interessati nel giro
dell'economia internazionale. Nel 1835, per esempio, il tonnellaggio mercantile
tedesco superava appena il livello del 1816; nel giro di un ventennio fu più
che raddoppiato e, nel 1870, era aumentato di tre volte e mezzo rispetto al
1816. Sempre nel 1835 ebbe inizio la costruzione della rete ferroviaria tedesca.
Le ferrovie diedero origine, mentre erano in costruzione, ad una fortissima
domanda diretta di capitali, lavoro, materie prime, e, non appena in funzione,
resero mercati e materiali accessibili a tutta una serie di attività
industriali. Fu proprio negli anni 1860 che la Germania sopravvanzò i suoi
rivali continentali (Francia e Belgio) come produttrice di carbone. La
rivoluzione industriale sembra prendesse slancio nel venticinquennio precedente
l'unificazione. Negli anni 1840 il lavoratore tedesco tipico era il contadino o
l’artigiano.
Due aspetti della rivoluzione industriale tedesca la distinguono da quelle
europee precedenti: il vigore e la rapidità con cui si sviluppò e la larga
dipendenza da fattori politici. Difatti l’industrializzazione tedesca fu un
atto politico deliberato. Le variazioni d’incremento del reddito nazionale
possono essere in gran parte ricondotte a decisioni consapevoli dei responsabili
della politica economica germanica.
La tradizione dell’interferenza governativa nel sistema economico , e anzi di
una diretta partecipazione del governo all’attività industriale, risaliva in
Germania a vecchia data. Il governo
prussiano gestiva nel XIX secolo ferriere, piombifere e miniere di carbone. Gli
stati tedeschi fecero venire tecnici stranieri, protessero l’industria locale,
e fornirono buona parte del capitale per il finanziamento a lungo termine delle
strade ferrate.
L’importanza della rivoluzione industriale, e la misura in cui essa implicava
l’applicazione di nozioni scientifiche ai processi produttivi sembrava fossero
valutate più pienamente in Germania che altrove. I politecnici e le università
tedesche furono istituzioni generosamente sovvenzionate dallo stato fin da
principio, e fornirono quelle risorse relativamente abbondanti di capacità
tecniche a cui fu indubbiamente dovuto il rapido sviluppo dell’industria
chimica ed elettrica.
Questi due aspetti preminenti della rivoluzione industriale tedesca non furono
naturalmente né l’uno né l’altro peculiare della Germania. Entrambi, al
contrario, si sono rivelati caratteristici di tutti, o quasi, i paesi giunti
tardivamente alla fase industriale. Anzitutto, le tradizioni politiche tedesche,
sebbene avessero senza dubbio la loro importanza, non furono l’unico fattore
che portò ad un accrescimento del ruolo statale nel processo di
industrializzazione: altre forze importanti agirono nello stesso senso. Era
abbastanza naturale che nei paesi in cui le condizioni per un rapido sviluppo
economico non si realizzavano spontaneamente, come era avvenuto in Inghilterra,
si cercasse di crearne con un programma deliberato, giacché le implicazioni sia
economiche, sia politico-militare della rivoluzione industriale costituivano per
i paesi meno favoriti dalla natura e dalla storia un incentivo potente ad
emulare l’esempio inglese. (Storia Economica Cambridge)
Stati Uniti
Raggiunta l’indipendenza
dall’Inghilterra, gli Stati Uniti divennero una nazione indipendente, ricca,
con un peso crescente nel contesto internazionale; crebbero in estensione,
occupando gran parte del continente; erano meta di una prima forte ondata di
emigrazione. (Cartiglia) L’ondata migratoria raggiunse proporzioni mai
prima toccate nella storia: vi furono in quel periodo 17 milioni di immigrati,
di cui 15 milioni vi si insediarono stabilmente. Erano in grande maggioranza
contadini poveri e analfabeti che furono impiegati nei lavori stradali e
ferroviari e nell’industria edilizia in un momento in cui la richiesta di
manodopera in quei settori dell’economia americana era enorme. Al fondo del
fenomeno migratorio, in questa fase storica che fu di generale incremento
demografico, vi furono dunque due fattori contrastanti: da un lato,
l’impetuoso sviluppo industriale degli Stati Uniti, dall’altro,
l’arretratezza economica di determinate zone agricole che conservavano una
struttura arcaica e semifeudale. Nel quadro di un’economia capitalistica che
aveva acquistato dimensioni mondiali e che era dominata dalla grande industria,
queste ultime fornivano alle fabbriche la maggiore o la sola “materia”
prima” di cui disponevano in abbondanza e che non potevano utilizzare: la
manodopera.
La situazione politica ed economica dell’Europa tra 1790 e 1815, profondamente
alterata dalle guerre rivoluzionarie e napoleoniche, ebbe un riflesso sugli
Stati Uniti: fecero affari d’oro i trasportatori marittimi (le grandi flotte
mercantili inglese e francese sono fuori del mercato, impegnate sul fronte
bellico) e gli esportatori (si
vendevano a prezzi molto remunerativi navi, legname, cotone); rincararono i
prodotti tessili di provenienza europea (vi era poca offerta, perché gran parte
della produzione era destinata agli eserciti, requisita per necessità
militari). Tuttavia, questo periodo felice per l’economia statunitense entrò
in crisi nel momento in cui si ristabilì la pace in Europa, e quindi
rientrarono in commercio i prodotti inglesi.In America, fino all’incirca il
1820, erano largamente presenti molte attività manifatturiere: sellai,
cappellai, fabbri, tessitori, calzolai, ebanisti, fornai, fabbricanti di carri.
Si trattava di artigiani, che producevano i beni per un mercato molto ridotto:
attività che, all’inizio, non vennero danneggiate dalla produzione
industriale europea a causa dell’alto costo dei trasporti. Tuttavia, appena
quest’ultimo decrebbe, i manufatti americani non riuscirono a concorrere con
quelli inglesi, di qualità migliore e di costo inferiore. In questo clima gli
Stati Uniti avviarono quel processo che li portò a diventare una potenza
industriale, trasformazione facilitata dal fatto che poterono attingere alle
conoscenze, alle innovazioni dell’industria britannica; essi non partirono da
zero, ma da una posizione ben più favorevole, perché l’informazione di ogni
genere, scientifica, meccanica, tecnica, era relativamente a portata di mano (la
comune lingua inglese rese questi scambi ancora più facili).
Gli Stati Uniti si mossero seguendo due direttive: si appoggiarono alla
tecnologia e alla scienza d’Europa, inglese in particolare; migliorarono la
propria produttività, cercando di colmare il divario attraverso la quantità, e
rifiutarono di diminuire i salari e gli interessi sul capitale (l’alto livello
di addestramento tecnico, di istruzione e di conoscenze dell’operaio americano
fece sì che la sua produttività oraria riducesse sostanzialmente la differenza
di costo rispetto ad un operaio inglese). In questo modo, se da una parte
morirono le piccole manifatture artigiane, dall’altra nacquero grandi imprese
capaci di sfornare una produzione sempre crescente.
L’industrializzazione statunitense si articola sostanzialmente in tre settori:
-
Il primo settore comprende le industrie produttrici di Farine, Legname,
Bevande alcoliche, ovvero che sfrutta le risorse del paese. Non avevano una
sviluppata componente di tecnologia, ma erano importanti in termini di
occupazione e di valore aggiunto. Queste imprese hanno influito sul tipo di urbanizzazione: città, come Cincinnati, Chicago, Buffalo, nacquero nelle zone
in cui il sottosuolo era particolarmente ricco di materie prime o presso punti
di giuntura delle linee di comunicazione.
-
Il secondo settore è caratterizzato dalle industrie capaci di dare un
costante, prolungato impulso al decollo della nazione: Calzoleria, Ferro, Cuoi,
Macchine e prodotti collegati “a valle” con il settore tessile (Prodotti
cotonieri, Abbigliamento, Prodotti lanieri). Tali attività erano concentrate
nel Nord-Est, sulla sponda dell’Atlantico, e che hanno determinato il nascere
delle cosiddette “Company Town”, città sorte attorno ad un singolo
comparto industriale.
-
Il settore più importante, per i suoi collegamenti a monte e a valle con
altre attività, è il tessile. Difatti, alcune ditte, che inizialmente
fabbricavano macchine tessili, poterono abbandonare quella prima attività,
diversificare i proprio prodotti, concentrare la propria produzione su altri
beni, sulle macchine utensili, sulle locomotive, su altri manufatti metallici
(ad esempio diviene rapidamente di massa la produzione delle stufe). A valle
c’erano l’abbigliamento e i prodotti finiti, per i quali è stata cruciale
l’invenzione della macchia da cucire.
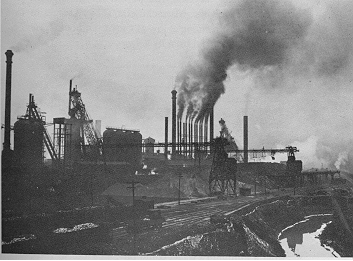 Va configurandosi una netta differenziazione tra il Nord, dove erano concentrate
le maggiori imprese di trasformazione, e il Sud, che divenne grandissimo
produttore di cotone. Quest’ultimo, per la sua economia altamente, ma
esclusivamente, specializzata nella produzione di cotone, era quasi totalmente
dipendente dal Nord: produceva una parte assai modesta dei beni di consumo, ma
la merce prodotta era destinata in gran parte ad essere esportata: così, il
reddito, molto cospicuo e rapidamente crescente che la regione ricavava da
quelle vendite, rifluiva al Nord, per l’acquisto di tutti quei beni di cui
aveva bisogno per vivere. L’incremento della popolazione urbana andò di pari
passo all’incremento dell’industria: se nel 1790 solo il 5% della
popolazione viveva in un centro urbano, quel valore era salito al 25% nel 1870.
Con l’aumento del numero dei lavoratori in fabbrica, si formò il proletariato
industriale, anche se le differenze sociali erano, in un primo periodo, meno
marcate che in Europa, dal momento che negli stati Uniti non è mai esistita la
nobiltà, e la nuova aristocrazia nascente si distingue in base al denaro. (Cartiglia)
Va configurandosi una netta differenziazione tra il Nord, dove erano concentrate
le maggiori imprese di trasformazione, e il Sud, che divenne grandissimo
produttore di cotone. Quest’ultimo, per la sua economia altamente, ma
esclusivamente, specializzata nella produzione di cotone, era quasi totalmente
dipendente dal Nord: produceva una parte assai modesta dei beni di consumo, ma
la merce prodotta era destinata in gran parte ad essere esportata: così, il
reddito, molto cospicuo e rapidamente crescente che la regione ricavava da
quelle vendite, rifluiva al Nord, per l’acquisto di tutti quei beni di cui
aveva bisogno per vivere. L’incremento della popolazione urbana andò di pari
passo all’incremento dell’industria: se nel 1790 solo il 5% della
popolazione viveva in un centro urbano, quel valore era salito al 25% nel 1870.
Con l’aumento del numero dei lavoratori in fabbrica, si formò il proletariato
industriale, anche se le differenze sociali erano, in un primo periodo, meno
marcate che in Europa, dal momento che negli stati Uniti non è mai esistita la
nobiltà, e la nuova aristocrazia nascente si distingue in base al denaro. (Cartiglia)
Giappone
A metà dell’Ottocento la
struttura della società giapponese era per molti aspetti simile a quella
dell’Europa medievale. La sua popolazione (circa 30 milioni) era divisa in
caste chiuse ed ereditarie, ordinate secondo una rigida gerarchia che aveva alla
sommità un piccolo gruppo di grandi signori (daimyo) possessori della
terra e detentori del potere amministrativo e giudiziario nei loro feudi. I
piccoli nobili (samurai) formavano i quadri degli eserciti feudali; al di
sotto di loro, nella gerarchia sociale, stavano le corporazioni di mercanti e
artigiani e i contadini. Il governo del paese era nelle mani dello shogun
(generalissimo) e del consiglio dei daimyo, mentre l’imperatore, anche
se venerato come un dio secondo i canoni della religione scintoista, era privo
dei effettivi poteri. Le frequenti rivolte contadine e l’opposizione dei ceti
mercantili, dell’aristocrazia progressista e degli intellettuali riformatori
si erano scontrate contro il rigido ordinamento sociale e l’oligarchia
politica. Dall’inizio del secolo XVII, quando si era imposta l’autorità
dello shogun e l’oligarchia feudale aveva preso il sopravvento sul
potere monarchico, il Giappone aveva interrotto ogni rapporto con il mondo
esterno e in particolare con l’Occidente, lasciando soltanto agli Olandesi la
possibilità di svolgere scambi commerciali, strettamente controllati,
attraverso il porto di Nagasaki.
Il rinnovamento interno del Giappone cominciò quando gli occidentali forzarono
il blocco, suscitando una forte reazione nazionalista che si diresse anche
contro l’ordinamento dello Stato e della società. Nel 1853 una spedizione
militare americana impose alle autorità giapponesi di aprire alcuni porti al
commercio occidentale. Poco dopo anche la Gran Bretagna, la Francia e la Russia
seguirono l’esempio degli Stati Uniti ed ottennero dal governo dello shogun,
in base ai cosiddetti “trattati ineguali”, l’apertura dei porti ed il
riconoscimento di privilegi economici e politici che limitavano la sovranità
giapponese: concessioni economiche, parziale esenzione dai diritti doganali,
diritto di sottrarsi alla giurisdizione giapponese etc.
La penetrazione economica occidentale, con le sue conseguenze, fece esplodere la
crisi latente nella società giapponese. La reazione nazionalista contro gli
stranieri e la lotta contro lo shogun e l’oligarchia feudale furono
promosse da un movimento che si raccolse attorno all’imperatore (movimento
lealista) e che fu guidato dalla parte progressista delle feudalità e dei samurai,
e dai mercanti. Il primo tentativo di ribellione, che aveva come programma la
restaurazione del potere imperiale e la cacciata degli stranieri, fu soffocato
da un intervento militare inglese, francese, olandese e americano.
L’imperatore Komei dovette riconoscere i “trattati ineguali” e abbandonare
l’atteggiamento di intransigente xenofobia. Il movimento lealista si orientò
allora verso la riforma interna. Con l’ascesa al trono del giovane imperatore
Mutsuhito (1868) incominciò il periodo del Meiji: il governo illuminato. Lo
shogunato fu soppresso ed il potere imperiale pienamente restaurato. Furono
attuate riforme che eliminarono gli aspetti più arcaici dell’ordinamento
feudale e diedero allo Stato una nuova struttura: l’amministrazione pubblica
fu affidata a funzionari statali (provenienti in parte dalla classe dei samurai);
furono soppresse le restrizioni all’iniziativa economica; fu introdotto un
sistema moderno di insegnamento; fu creato un esercito nazionale sulla base del
servizio militare obbligatorio. A parte qualche tentativo di opposizione feudale
la maggior parte della classe dirigente non solo aderì alla “rivoluzione”
del Meiji, ma anzi si fece promotrice della trasformazione istituzionale, basata
sul rafforzamento dell’autorità imperiale. La riforma fu quindi attuata come
un rinnovamento interno della classe dirigente, la quale, allargata ai ceti
mercantili, continuò a mantenere il suo dominio nella società e nello Stato.
Il nuovo governo si pose subito l’obiettivo di dare al paese una moderna
attrezzatura industriale, che appariva come la condizione indispensabile per una
efficace difesa dall’invadenza occidentale. Fu soprattutto sotto questo
aspetto (più dal punto di vista politico) che il Giappone assunse
come modello i paesi più progrediti dell’Occidente ed in particolare la
Germania. Giovani giapponesi furono inviati nelle università inglesi e
americane e tecnici stranieri furono chiamati ad operare in Giappone. Poiché
mancavano le condizioni per un autonomo sviluppo capitalistico del tipo di
quello che si era svolto in Europa, lo Stato assunse direttamente il compito di
creare l’ossatura fondamentale dell’industria. L’enorme onere finanziario
dell’industrializzazione ricadde in gran parte sulle campagne sottoposte ad
una durissima pressione fiscale. Un’altra parte dei capitali necessari venne
dal prestito straniero e interno e dalla confisca dei beni dei signori ribelli.
Create con fondi pubblici, le nuove industrie furono poi trasferite a privati, a
partire dal 1881, a condizioni particolarmente favorevoli, e continuarono ad
essere sostenute dallo Stato con sovvenzioni, commesse ed incentivi di vario
genere.
Il modo particolare in cui il Giappone realizzò la sua industrializzazione, con
una rivoluzione dall’alto promossa dalle stesse classi dirigenti ed attuata
dallo Stato, gli permise di abbreviare i tempi della sua trasformazione
economica. Fu ben presto costruita una densa rete ferroviaria, sorsero
acciaierie e cantieri navali, la produzione tessile superò lo stadio
artigianale, si sviluppò dopo il 1890 l’industria idroelettrica. Tuttavia, il
sistema economico così creato ebbe anche alcuni caratteri negativi, che
derivavano dalla sua stessa origine. Le concessioni delle fabbriche furono
riservate a consorzi di grandi capitalisti che ebbero il monopolio di una larga
parte della produzione e che conservarono sempre la tendenza a ricorrere alla
protezione dello Stato e dell’autorità militare. Il suo stesso modo di
formazione impose inoltre al capitalismo giapponese una precoce tendenza
espansionistica, che divenne un elemento essenziale del sistema ed improntò di
sé la vita politica ed i rapporti sociali. Mancavano infatti all’interno le
condizioni per l’ulteriore espansione dell’economia industriale, poiché la
povertà dei contadini e l’arretratezza del sistema agricolo rendevano del
tutto insufficiente il mercato nazionale. Il grande capitalismo giapponese
dovette cercare all’estero le possibilità e le condizioni del suo sviluppo.
Ben presto, dunque, l’ideologia del Grande Giappone ed il programma
nazionalista e razzista di affermazione del dominio nipponico su tutta l’Asia
orientale conquistarono la classe dirigente. In tal modo, il nuovo Stato sorto
dalla “rivoluzione del Meiji” ebbe un’impronta bellicista che si manifestò
con la guerra del 1894 contro la Cina e con il rapido inserimento del Giappone
tra le potenze imperialistiche. (Villari)
Italia
L’Italia si trovava in una
condizione di ritardo rispetto alle altre nazioni europee che si aggravava di
giorno in giorno. Il problema riguardava sia l’agricoltura, che era entrata in
crisi intorno agli anni `80 in seguito all’immissione del grano americano nel
mercato internazionale (che aveva provocato una grave caduta dei prezzi
agricoli), sia l’industria. I nuclei di borghesia industriale operanti nelle
regioni settentrionali rivendicavano un più energico impegno dello Stato ed un
indirizzo di politica economica più adatto a sostenere l’incipiente
industrializzazione. Poiché la spontanea iniziativa degli imprenditori e la
costruzione di ferrovie ed opere pubbliche non erano sufficienti a determinare
una profonda trasformazione dell’economia e la creazione di un moderno
apparato industriale, era necessario che il concorso dello Stato fosse più
ampio e che lo sviluppo capitalistico-industriale non fosse abbandonato al
libero svolgimento delle forze economiche ma fosse sostenuto e diretto
dall’alto. Una simile impostazione della politica di sviluppo comportava una
forte pressione sull’agricoltura. La struttura politica del paese permetteva
di riversare sulle masse rurali il peso dell’industrializzazione forzata e
dall’alto. Gli imprenditori agrari non avrebbero quindi avvertito un disagio
eccessivo ed avrebbero potuto continuare a portare avanti la trasformazione dei
rapporti produttivi e l’accumulazione capitalistica nelle campagne.
L’aspetto negativo di questa scelta sarebbe stata l’immobilizzazione delle
strutture agrarie del Mezzogiorno. La conferma e la difesa ad oltranza del
dominio sociale dei “galantuomini” equivaleva infatti al mantenimento delle
condizioni di arretratezza del Mezzogiorno ed all’inutile aggravamento delle
sofferenze di milioni di contadini. Era un’incognita di cui in quel momento
pochissimi avvertirono la gravità ed il significato negativo per le prospettive
di progresso economico, civile e politico di tutto il paese: ciò che contava
era assicurare la continuità del
consenso delle classi dominanti meridionali del momento in cui lo Stato e la
società si accingevano a realizzare una svolta di importanza fondamentale, che
avrebbe indubbiamente provocato forti tensioni sociali.
Capisaldi di questa politica furono l’adozione del protezionismo doganale e le
sovvenzioni dirette ad alcuni complessi industriali di particolare importanza. I
dazi di importazione dei manufatti industriali cominciarono ad essere elevati
nel 1878. Subito dopo si ebbe una fase di moderato incremento dell’industria
(dal 1881 al 1887) che fu particolarmente sensibile nei settori metallurgico,
meccanico e chimico. Una parte importante in questa fase ebbero le sovvenzioni
statali, che furono date alla prima grande acciaieria (la società Terni) la cui
costruzione fu iniziata nel 1884, all’industria cantieristica, alle società
di navigazione. Nello stesso periodo sorse in Italia anche la società Edison,
la prima industria idroelettrica. Non era ancora il grande slancio, l’inizio
di un diffuso e autonomo movimento di sviluppo. La contemporanea crisi agraria
influì infatti negativamente sull’andamento generale dell’economia,
rallentando la formazione e l’investimento di capitali privati e mantenendo
basso il livello della domanda del mercato.
Si dovette quindi portare ancora più a fondo la politica economica già
avviata. La vera e propria svolta protezionista si ebbe nel 1887, con
l’adozione di una tariffa che in pratica eliminò la concorrenza straniera. La
protezione fu estesa, oltre che ai prodotti industriali, anche ad alcuni
fondamentali prodotti alimentari, come lo zucchero, il riso e soprattutto il
grano, con un criterio che i teorici dell’economia giudicarono allora
contraddittorio e controproducente. È ancora oggi oggetto di discussione tra
gli studiosi se la tariffa del 1887 – che protesse in modo particolare
l’industria tessile e siderurgica e la cerealicoltura – abbia contribuito in
modo determinante all’espansione dell’industria italiana. È certo, comunque
che a partire dal 1896 si verificò il vero e proprio “decollo”
dell’industria ed ebbe inizio una fase di intensa espansione che durò fino al
1908. Fu questo il periodo in cui si formò il cosiddetto triangolo industriale,
comprendente le tre regioni nord-occidentali del Piemonte, della Lombardia e
della Liguria. Era naturale che la politica di industrializzazione dovesse dare
i suoi risultati in queste regioni in cui il processo di sviluppo
dell’agricoltura aveva già raggiunto un sufficiente grado di maturità ed
aveva dato luogo ad una relativamente intensa accumulazione capitalistica. Nella
fase conclusiva – che segnò veramente il passaggio dell’Italia
nord-occidentale da regione agricola a regione industriale – ebbero un ruolo
determinante le banche, che fecero affluire capitali, in parte proveniente
dall’estero, alle imprese industriali nascenti o in via di espansione.
Sorta sulla base della protezione statale e della compenetrazione con il
capitale bancario, l’industria italiana assunse fin dall’origine un
carattere tendenzialmente monopolistico. “Come in Germania, (le banche) furono
sempre desiderose di “disciplinare la produzione” di determinati settori
industriali, espressione eufemistica che significava in realtà l’imitazione o
abolizione della concorrenza, e promozione di accordi monopolistici di vario
tipo” (Gerschenkron). Più che sulla competizione economica e
sull’aggiornamento tecnologico l’industria puntò sul dominio privilegiato
del mercato, dei bassi salari, sulle commesse statali, sulla concentrazione
delle imprese. Inoltre, per il modo in cui avvenne, il processo di
industrializzazione non eliminò gli squilibri esistenti nel paese, e in primo
luogo lo squilibrio tra nord e sud, che anzi si aggravò. I nuovi contrasti
sociali sorti dalla formazione della grande industria e dal connesso sviluppo
del proletariato operaio furono particolarmente esasperati, dal momento che gli
operai italiani erano sottopagati rispetto alla media europea, avevano i più
lunghi orari di lavoro, mancavano di ogni tipo di assistenza ed erano duramente
ostacolati nei loro tentativi di organizzazione. D’altra parte, anche nelle
zone più arretrate del paese si ebbe una ripresa delle lotte contadine,
contemporaneamente all’inizio della grande ondata migratoria, che si venne poi
via via ingigantendo fino al 1913. L’ultimo decennio del secolo fu quindi uno
dei periodi più tempestosi e drammatici della storia italiana. (Villari)
Russia
In Russia, i contadini erano
organizzati nelle comunità di villaggio (mir) che amministravano le
terre sottratte alla nobiltà e al demanio, dividendole in quote tra le famiglie
dei coltivatori. Erano responsabili collettivamente attraverso il mir,
del pagamento del riscatto delle terre e delle tasse. L’equilibrio di questo
sistema, già precario per l’insufficienza della terra che era stata assegnata
alle comunità e per l’onere finanziario del riscatto, fu ulteriormente scosso
dall’aumento dalla popolazione – da 70 milioni nel 1855 a 125 milioni nel
1895 – che impose continue redistribuzioni e restrizioni delle quote
contadine, e dalle conseguenze dell’industrializzazione.
Con l’avvento di Alessandro III, che accantonò tutti i progetti di riforma
che erano stati abbozzati negli anni precedenti e aumentò la repressione
poliziesca e il regime autocratico, si accrebbe il controllo della burocrazia
statale sulle comunità rurali. Di questo aspetto della reazione di Alessandro
si valse il governo, nel momento in cui fu avviata la politica di
industrializzazione, per mantenere immobili le strutture sociali delle campagne
e, in particolare, per impedire la disgregazione del mir, con duplice
scopo di intensificare la pressione fiscale e mantenere la stabilità politica
del paese.
Anche in questo caso la creazione di un moderno apparato industriale, tra il
1890 e il 1900, fu resa possibile dall’intervento dello Stato e fu realizzata
senza una preventiva o contemporanea trasformazione dell’agricoltura. La
politica di industrializzazione, di cui fu artefice il ministro delle Finanze
Sergej J. Vitte (1849-1915), si basò sull’incoraggiamento all’afflusso di
capitale straniero e sull’intervento statale, sia sotto l’aspetto di
garanzie ai capitali stranieri che di finanziamenti diretti, sovvenzioni,
contratti governativi, protezioni doganali, sostegno alla concentrazione delle
imprese ed all’introduzione della tecnologia più aggiornata. Il risultato fu
che, ai primi del Novecento, la Russia aveva alcune importanti zone industriali
(la regione di Mosca, in cui predominava l’industria tessile, quella
metallurgico-meccanica di Pietroburgo, la zona mineraria degli Urali e quella
petrolifera di Baku) in mezzo ad un immenso territorio che conservava in gran
parte intatto il suo carattere agricolo arretrato.
Non sorprende perciò che lo sviluppo industriale abbia incontrato resistenze ed
incomprensioni sia nelle classi dirigenti che, per ragioni diverse,
nell’opposizione. I gruppi politici più conservatori lo osteggiarono
soprattutto per spirito nazionalistico. “Molte persone, compreso
l’imperatore – scrisse il Vitte nelle sue memorie – si opposero
all’importazione del capitale straniero in Russia, per considerazioni
puramente nazionaliste. Sostenevano che le risorse nazionali russe dovevano
essere sfruttate dai “veri” Russi e per mezzo di denaro russo. Trascuravano
il fatto che il capitale disponibile in Russia era molto scarso. Ne risultava
che le concessioni industriali erano accordate abitualmente a “veri” Russi,
che dopo le vendevano a stranieri e intascavano cospicue somme di denaro mal
acquistato. Citerò, per esempio, il caso di un colonnello a riposo, che ottenne
una concezione di miniere d’oro nella penisola del Kamciatka. Alcuni mesi
dopo, la vendette ad una compagnia straniera”. (Villari)