GLI SPETTRI
La teoria sull’elettromagnetismo di Maxwell Ŕ stata di determinante importanza, oltre che per lo sviluppo delle telecomunicazioni di massa, anche per la nascita ed il rapidissimo progresso che l’astrofisica ha conosciuto negli ultimi due secoli. La teoria ondulatoria del fisico scozzese consentý infatti di avvalorare fisicamente molte delle scoperte empiriche riguardanti i fenomeni celesti.
Uno dei
fondamentali metodi dell’osservazione dell’universo Ŕ infatti la spettroscopia
che trova i suoi fondamenti nelle proprietÓ fisiche della luce e di altre onde
elettromagnetiche, quali la dispersione, la diffrazione e l’interferenza.
Questo sistema d’indagine vede la luce in concomitanza con l’invenzione dello spettroscopio, uno strumento capace di disperdere le radiazioni elettromagnetiche, separando le diverse lunghezza d’onda e raccogliendole poi sopra uno schermo.
Il primo utilizzo dello spettroscopio nello studio delle stelle si deve a Wollaston nel 1802 e successivamente a Fraunhofer (SB) nel 1814, i quali scoprirono le righe di assorbimento (ST) che attraversano lo spettro altrimenti continuo prodotto dal Sole. La spiegazione della presenza di tali righe Ŕ dovuta per˛ a Kirchhoff (SB) che formulando le tre leggi fondamentali della spettroscopia (1859) ne allarg˛ l’utilizzo alla fisica microscopica.
E’ questa la data che segna il sorgere dell’astrofisica come mezzo imprescindibile nello sviluppo dell’astronomia, e nello studio dell’evoluzione stellare.
La spettroscopia ha rivestito un importante ruolo anche nelle maggiori conquiste della meccanica quantistica e nell’individuazione del red-shift (ST) che dimostra l’effettiva espansione dell’universo.
Enunciamo ora le tre leggi di Kirchhoff sui tipi di spettri individuati sperimentalmente, in quanto da esse non si pu˛ prescindere:
 1)Uno spettro continuo
Ŕ emesso da un solido incandescente, liquido o un gas molto denso. Lo spettro di
emissione risulta a righe per un gas a bassa pressione.
1)Uno spettro continuo
Ŕ emesso da un solido incandescente, liquido o un gas molto denso. Lo spettro di
emissione risulta a righe per un gas a bassa pressione.
2)Tutte le sostanze assorbono radiazioni aventi la stessa lunghezza d’onda di quelle che le stesse sostanze sono capaci di emettere.
3)Nel caso in cui una radiazione prodotta da una sorgente a temperatura elevata T attraversa un gas surriscaldato e avente temperatura t < T, otteniamo un spettro continuo solcato da linee nere dette di assorbimento.
Abbiamo visto come gli spettri di emissione della materia dipendano in maniera sensibile dalla temperatura e dalla pressione caratterizzanti la materia stessa. Attraverso questi due parametri sono stati formulati i criteri principali per la classificazione degli spettri delle stelle. Tale classificazione ha evidenziato la composizione chimica di svariati tipi di stelle, come le classi R e N caratterizzate da intense righe del carbonio, o la classe S in cui predominano bande molecolari dell’ossido di Zirconio (ZrO); altre stelle vedono la predominanza dell’azoto o del carbonio e dell’ossigeno.
I valori di pressione e temperatura cui Ŕ supposta trovarsi una stella sono fatti derivare anche dalla luminositÓ della stella medesima che infatti Ŕ condizionata dalla densitÓ dei materiali di cui Ŕ composta, ed Ŕ individuata nello spettro dalla maggiore o minore intensitÓ della radiazione raccolta.
La spettroscopia Ŕ in grado, in alcuni casi, di fornire informazioni persino sul movimento e sulla velocitÓ dei corpi celesti.
Un grande contributo allo sviluppo della spettrografia come metodo di studio dell’universo Ŕ stato fornito nella seconda metÓ di questo secolo dall’introduzione dei telescopi orbitanti e dei satelliti artificiali i quali trovandosi nel vuoto oltre l’atmosfera terrestre possono raccogliere e valutare dati relativi alla ricezione di onde elettromagnetiche quali l’ultravioletto, l’infrarosso, i raggi X e i raggi g , che non possono essere rilevate sulla superficie terrestre a causa della funzione filtrante dell’atmosfera.
Questo aspetto dell’indagine stellare attraverso le onde elettromagnetiche porta alla scoperta di nuove caratteristiche dell’universo, profondamente diverse da quelle che erano considerate peculiaritÓ imprescindibili nell’organizzazione del mondo celeste.
L’analisi
dei raggi ultravioletti presenti al di fuori dell’atmosfera terrestre ha portato
all’individuazione di stelle che ci appaiono azzurre e bianche e che risultano
caratterizzate da temperature che variano da 10.000 a 30.000 gradi, inoltre ha condotto
alla scoperta di strati esterni che circondano le stelle e risultano fortemente rarefatti
e di numerose nuove galassie.
La raccolta di radiazioni nella fascia dell’infrarosso Ŕ stata di grande importanza nell’osservazione di anelli di polvere attorno ad alcune stelle brillanti e relativamente vicine come Vega, e di galassie significativamente intense.
I raggi g essendo caratterizzati dal massimo valori di energia possibile per un fotone risultano importanti per l’osservazione del quantitativo energetico distribuito nell’universo. A tal proposito dobbiamo distinguere svariati meccanismi che portano alla loro produzione.
Interazione fra due protoni oppure fra un protone e un nucleo pi¨ pesante, o fra due nuclei.
Quando un elettrone di alta energia interagisce con un fotone di bassa energia gli trasferisce parte della sua energia trasformandolo in un fotone gamma.
Un elettrone interagendo con un campo elettrico e risultando da esso frenato, libera la sua energia sotto forma di fotone gamma (se l’energia Ŕ abbastanza elevata).
Un elettrone che si muove a grande velocitÓ Ŕ frenato da un campo magnetico di molti miliardi di Gauss emette un fotone gamma. (Nel caso in cui il campo magnetico sia dell’ordine del milionesimo di Gauss si produce un fotone radio).
La distribuzione della radiazione gamma ha permesso di identificare sorgenti quali nubi residui di supernovae e altre che presentano bruschi aumenti di intensitÓ nel campo di tale radiazione, ma che risultano ancora essenzialmente misteriose.
La scoperta della produzione da parte dei corpi celesti di radiazioni X risale al 1962, anno in cui si individu˛ una radiazione diffusa in tutte le direzioni del cielo e una sorgente situata nella costellazione dello Scorpione. Il successivo approfondimento delle ricerche sulle radiazioni X ha determinato importanti risultati come la scoperta che tutte le stelle emettono raggi X in maniera da formare una corona. Numerose sorgenti X sono individuabili nelle nubi derivate dall’esplosione di supernovae e in lontane galassie come le Quasar.
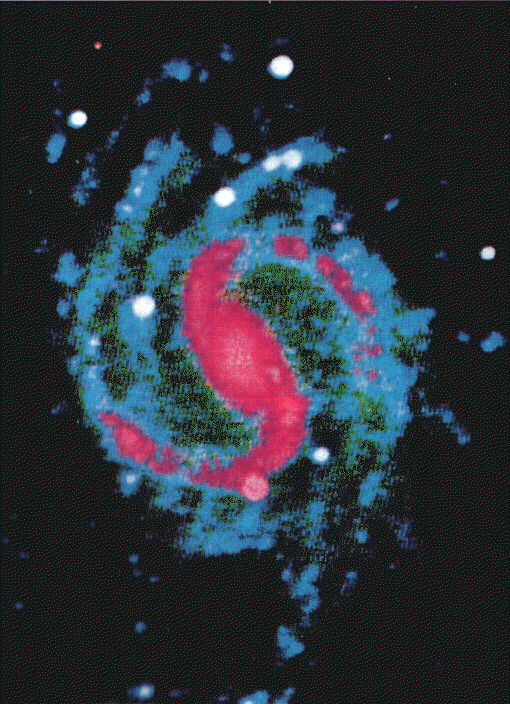 Un altro
importante elemento di valutazione nella considerazione di fenomeni stellari Ŕ
l’emissione da parte dei corpi celesti delle onde radio. Uno strumento che ci
consente di ampliare la nostra conoscenza a mezzo di tali radiazioni Ŕ il radiotelescopio
che registra le onde radio provenienti dall’universo. Spesso si connette al
radiotelescopio un apparato radar in grado di stabilire la distanza delle stelle che
inviano i raggi elettromagnetici.
Un altro
importante elemento di valutazione nella considerazione di fenomeni stellari Ŕ
l’emissione da parte dei corpi celesti delle onde radio. Uno strumento che ci
consente di ampliare la nostra conoscenza a mezzo di tali radiazioni Ŕ il radiotelescopio
che registra le onde radio provenienti dall’universo. Spesso si connette al
radiotelescopio un apparato radar in grado di stabilire la distanza delle stelle che
inviano i raggi elettromagnetici.
La finestra radio, accessibile dal suolo, Ŕ limitata da fenomeni di assorbimento per quanto riguarda le onde corte e da fenomeni di riflessione imputati alla ionosfera quando la lunghezza d’onda supera 50 metri. La capacitÓ di osservazione attraverso le onde radio Ŕ stata comunque incrementata nel corso di questo secolo grazie all’introduzione dei radiointerferometri, strumenti costituiti dal collegamento di numerosi radiotelescopi, le osservazione dei quali vengono fatte interferire tra loro in modo da acuire la direzionalitÓ delle onde radio.